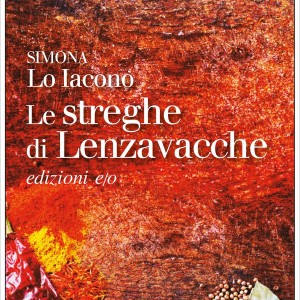“Le Streghe di Lenzavacche” di Simona Lo Iacono” Edizioni E/O
Descrizione
(dal sito dell’editore):
Le streghe di Lenzavacche vennero chiamate nel 1600 in Sicilia un gruppo di mogli abbandonate, spose gravide, figlie reiette o semplicemente sfuggite a situazioni di emarginazione, che si riunirono in una casa ai margini dell’abitato e iniziarono a condividere una vera esperienza comunitaria e anche letteraria. Furono però fraintese, bollate come folli, viste come corruttrici e istigatrici del demonio. Secoli dopo, durante il fascismo, una strana famiglia composta dal piccolo Felice, sua madre Rosalba e la nonna Tilde, rivendica una misteriosa discendenza da quelle streghe perseguitate. Assieme al giovane maestro Mancuso si batteranno contro l’oscurantismo fascista per far valere i diritti di Felice, bambino sfortunato e vivacissimo.
Recensione:
Rosalba, insieme a sua madre Tilde, è depositaria di un’antichissima tradizione erboristica ed erede di una temuta stirpe di indovine. Per questo in paese le due sono guardate male e quando arriva il tanto adorato figlio Felice, si arroccano come reiette in una casa sperduta. Felice è il figlio della colpa, di un padre senza nome che non ha lasciato altra eredità che un destino ingiusto. Felice ha la testa storta, non sta in piedi. Nonna Tilde e l’amico farmacista ingegnano per lui un meccanismo che lo tenga ritto in piedi e na giostrina su cui sputare per comporre parole. Ma un giorno Felice sorprende tutti: si incaponisce che vuole andare a scuola. Figuriamoci, pensa Rosalba, chi lo prenderebbe mai in un’epoca che pretende forza e perfezione fisica?
Ma in quel settembre del 1938 arriva in contrada Lenzavacche un nuovo maestro. Ama la cultura, non i banchi di scuola e, sebbene obbligato ad adempiere i compiti ministeriali, si ribella piano alle imposizioni di regime. Anche lui è a suo modo un diverso e il paese se ne accorge, la sua classe si spopola e il suo impiego vacilla. Ma Alfredo Mancuso non è tipo da arrendersi: si rimbocca le maniche è gli studenti li va a cercare per strada, al mercato, raccontando storie, affascinandoli con i suoi racconti sulle disavventure di Giufà. I monologhi di Rosalba, che si rivolge sempre all’adorato figlio Felice, e le missive del maestro a una zia dal nome e indirizzo mai pronunciati, si alternano paralleli, non si incontrano fino a quando si rende necessario escogitare il modo di mandare a scuola Felice che ha espresso questo unico desiderio e si deve trovare il modo per accontentarlo.
Le atmosfere di questo romanzo “stregano” e ammaliano il lettore, lo trasportano in epoche lontane di megere e pozioni, mavarie e pulsioni ancestrali. In una Sicilia assolata e ventosa di Scirocco, con le sue tende svolazzanti all’afa del pomeriggio e scialli e tenerumi.
Il linguaggio dell’autrice stupisce, abbraccia, sprofonda nella natura e nella cultura della sua terra, fra metafore originali e parole della tradizione, reinventa la lingua e la riscopre in quelle stesse parole del dialetto. “Gli occhi che sbocciavano come sassi da un fiume”, “silenzio ossuto”, “Venere in crescenza e Mercurio che profetava sventure”… Un romanzo sorprendente dove tutto sembra fuori posto e invece riesce a trovare la sua collocazione, candidato al premio Strega dove mi auguro riscuota tutto il successo che merita.
Anita
Estratto: I cap.
“La prima volta in cui ti vidi eri talmente imperfetto che pensai che nonna Tilde avesse ragione. Avrei dovuto mettere sotto la tua culla otto pugni di sale, bere acqua di pozzo e invocare le anime del purgatorio. Poi dire tre volte: «Maria Santissima abbi pietà di lui», affidarti alle mani del primo angelo in volo e assicurarti al collo una catena della buona morte. Non lo avevo fatto. D’altra parte eri un imprevisto, e con gli imprevisti non si allestiscono scongiuri e preparativi. Al più qualche rimedio per i tuoi occhi allungati, la fronte bitorzoluta, il broncio spellato dalle troppe spinte. Nonna Tilde ti ha guardato scettica ed è corsa a chiamare un sacerdote pontificando che solo gli esorcismi ti avrebbero salvato dalla malasorte. Poi ti ha sciacquato dal sangue del parto, ti ha sistemato sul mio seno ed è sparita per andare a seppellire la placenta sotto il vecchio noce. In silenzio, ha invocato i nomi degli antenati. Ma la luna calava invece che alzarsi, non era tempo di marea né di santi, i fantasmi tacevano e non una stella brillava nella notte. Tutti cattivi presagi, figlio mio, ma tu eri nato, e pur squadernato da un vento di sfortuna, ti chiamai Felice, e decretai che quello era il primo passo per ribaltare il destino.
Infatti si comincia sempre col nome. Poi si passa al resto, alle discendenze e ai ricordi di chi ci ha preceduto, reliquie che adesso raccolgo per spiegarti il tuo passato. La casa in cui sei nato, per esempio. Appartiene alla mia famiglia da molte generazioni. Una villino della caccia in cui campeggia lo stemma nobiliare, sormontato dal nome: Rinauro Astolfo. All’interno si susseguono saloni lastricati da ceramiche, soffitti a volta, quadri da cui occhieggiano i bisavoli. È un casaleno bucato da cunicoli e porte girevoli, cucine di maiolica, refettori in legno. Ogni sedia ha un segnale diverso, e una numerazione al femminile su cui puoi leggere in successione: prima, secunda, tertia. Nei primi mesi di vita sbirciavi i gradoni dipinti con fronte aggrottata, spiavi la piramide di riccioli sotto cui gli antenati lanciavano occhiate, cercavi una somiglianza lontana con il tuo sangue. Ma non c’era, figlio mio. Nessuno somigliava a te, agli zigomi montagnosi, alla testa ciondolante che i medici non riuscivano a raddrizzare. Ne avevo consultati a decine fin dall’inizio, ignorando nonna Tilde che preparava estratti di finocchio e pensava che ai difetti fisici si rimediasse con le erbe. Vi trovavo in cucina tra fumi di decotti, con te legato a un palo per tenere la rotta e la nonna che armeggiava trascurando ogni diagnosi. Era convinta che le tue mancanze fossero in fondo benefici e che a non camminare ti saresti risparmiato i calli che affliggevano il trisavolo Ferdinando, a non parlare correttamente avresti guadagnato pace e salute. Quanto al fatto che non avresti compreso il mondo, trovava che fosse un sollievo e non faceva che blaterarti in faccia: ti invidio, Felice, nipote sciancato e senza angeli.
Cara zia, sono arrivato questa mattina col treno delle cinque. Ad attendermi, come previsto, c’erano i proprietari della pensione, che mi hanno scortato fino in paese. Un piccolo centro, che gravita intorno a una chiesa e a una piazza. In apparenza nessuno ha badato a me. Ho saputo dopo, invece, che al mio passaggio i vecchi che dondolavano sulle sedie hanno alzato la testa, e che improvvisamente, come se un ordine invisibile fosse volato di bocca in bocca, la notizia che il nuovo maestro era arrivato a Lenzavacche non era sfuggita a nessuno. Prima ancora di registrare il mio nome in pensione, tutti sapevano che Alfredo Mancuso era lì, e che il giorno dopo avrebbe preso servizio presso l’istituto Maria Montessori. Ti abbraccio, cara zia, e aspetto di ambientarmi per farti avere altre notizie. Da Lenzavacche, 3 settembre 1938 Tuo, Alfredo”